ENRICO CARUSO
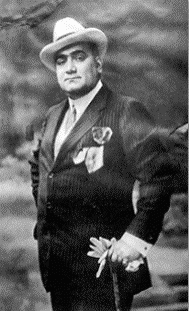 Caruso nasce a Napoli il 25 febbraio 1873 da una famiglia povera di originaria della provincia di Caserta (Piedimonte d’Adife che, oggi, ha cambiato nome in Piedimonte Matese). I genitori riescono appena a sbarcare il lunario: la madre, Anna Baldini, lavorava come donna delle pulizie e il padre, Marcellino, come operaio metalmeccanico e il ragazzo cresce nel rione di Sangiovannello agli Ottocalli. Enrico frequenta la scuola fino a dieci anni, poi segue le orme del padre che lo porta con sé a lavorare. Fortunatamente la madre decide di iscriverlo ad una scuola serale dove capisce di essere portato per il disegno e comincia a progettare alcune fontane per la fonderia in cui lavorava. Questo gli permette di coltivare la passione per l’arte che, comunque, trovava massima attraverso la voce. Voce che ben presto cattura le attenzioni di un’amica di famiglia (Rosa Barretti), la quale insiste per presentarlo al parroco e per inserirlo nel coro della chiesa. Successivamente si trasferisce e comincia a cantare nella Chiesa di Sant’Anna delle Paludi dove il parroco Giuseppe Bronzetti gli dà
Caruso nasce a Napoli il 25 febbraio 1873 da una famiglia povera di originaria della provincia di Caserta (Piedimonte d’Adife che, oggi, ha cambiato nome in Piedimonte Matese). I genitori riescono appena a sbarcare il lunario: la madre, Anna Baldini, lavorava come donna delle pulizie e il padre, Marcellino, come operaio metalmeccanico e il ragazzo cresce nel rione di Sangiovannello agli Ottocalli. Enrico frequenta la scuola fino a dieci anni, poi segue le orme del padre che lo porta con sé a lavorare. Fortunatamente la madre decide di iscriverlo ad una scuola serale dove capisce di essere portato per il disegno e comincia a progettare alcune fontane per la fonderia in cui lavorava. Questo gli permette di coltivare la passione per l’arte che, comunque, trovava massima attraverso la voce. Voce che ben presto cattura le attenzioni di un’amica di famiglia (Rosa Barretti), la quale insiste per presentarlo al parroco e per inserirlo nel coro della chiesa. Successivamente si trasferisce e comincia a cantare nella Chiesa di Sant’Anna delle Paludi dove il parroco Giuseppe Bronzetti gli dàl’opportunità di cimentarsi in opere come la Messa di Mercadante e I briganti nel giardino di Don Raffaele, dove interpreta il ruolo di un bidello. Intanto, incomincia anche ad affermarsi tra i posteggiatori, finché non viene notato da Amalia Gatto che decide di presentarlo ai suoi due primi maestri di canto, Schiaridi e De Lutio, che gli impartiscono le prime lezioni. Successivamente comincia a cantare anche in un'altra chiesa, quella di San Severino e Sossio, dove prende lezioni dal maestro Amitrano. Passa, poi, sotto la guida del maestro Sarnataro e comincia ad esibirsi al Caffè dei Mannesi dove si confronta con altre figure emergenti della canzone napoletana. In seguito viene scritturato dalla birreria Strasbugo di Piazza Municipio insieme ad alcuni artisti del Cafè Chantant; proprio grazie ad uno di questi intraprende la via del teatro. All’inizio si tratta di piccole rappresentazioni, serate musicali alle terrazze o agli stabilimenti balneari per allietare il borghesi e turisti. Ma, ben presto, questa dimensione comincia a stargli stretta.
tempi. In quel periodo Enrico fu costretto ad affrontare la morte per tubercolosi della madre, mentre il padre si risposa con Maria Castaldi, che riesce comunque a fare breccia nel cuore di Caruso, il quale ritrova la voglia
per continuare la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Nel 1894 le lezioni si interrompono perché Enrico viene chiamato nell’esercito a Rieti, ma, fortunatamente, dopo solo un mese e mezzo viene congedato grazie al maggiore Magliati che, appassionato di musica, decide di non rovinare il talento che aveva di fronte con le fatiche della vita militare e, sfruttando le leggi del tempo, lo fa sostituire dal fratello maggiore Giovanni, permettendogli di continuare gli studi. Caruso si sente pronto per l’esordio e il maestro Vergine riesce a farlo scritturare al Teatro Mercadante per la Mignon di Ambroise Thomas, ma, dopo le prove, non viene accettato. Successivamente si ritrova a dover fronteggiare un altro fiasco al San Carlo di Napoli, dove viene chiamato
per sostituire un tenore ammalato nel Faust di Gounod, ma l’emozione e l’inesperienza non gli permettono di terminare l’esibizione. Fortunatamente non deve aspettare molto per una seconda occasione.
per le conseguenza che ha nella vita sentimentale del tenore napoletano. Infatti, in questo periodo conosce il soprano Ada Giacchetti che, sebbene sia già sposata con un figlio, ha con lui una relazione di 11 anni, dalla quale nascono Rodolfo (1898) ed Enrico jr (1904). L’amore, però, finirà bruscamente quando la donna decide di scappare con l’autista cercando anche di estorcere del denaro a Caruso. La vicenda finisce davanti ad un giudice che condanna la Giacchetti a tre mesi di carcere e 100 lire di multa. Nel 1898 si registra l’esordio al Teatro Lirico di Milano al quale seguì, nel 1899, il primo importante ingaggio all’estero, a Pietroburgo in Russia e, poi, a Lisbona, Roma, Montecarlo, Londra e Buenos Aires.
Metropolitan di New York. Ma, nonostante la rivincita, la decisione di lasciare Napoli è ormai presa e, quando nel 1904, decide di comprare una casa in Italia, la scelta cade sulla provincia di Siena, più precisamente sul comune di Lastra a Signa dove compra, restaura e arricchisce con numerose opere d’arte Villa di Bellosguardo. Tutto questo, però, non vuol dire che Caruso decida di rinnegare le sue origini, anzi, torna a Napoli spesso, ma si rifiuta sempre di cantare. Anche quando viene chiamato per beneficenza decide di donare solamente del denaro mantenendo fede al suo giuramento. Napoli rimane comunque la città in cui il tenore decide di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita.
Era lu tiempo antico
Pe' me lu paraviso
ca sempe benedico
pecché cu nu surriso
li braccia m'arapive
e 'mpietto me strignive.
Chino 'e passione
currevo 'mbraccio a te.
Ma tu ca sì 'nfamona
tu te cuffiave 'e me.
Tu te ne sì gghiuta
cu n'auto 'nfantasia
e a chesta vita mia
'na fossa aje araputo!
Di essa è disponibile anche un'altra versione che è riportata di seguito:
Era lu tiempo antico
comm'era 'o Paraviso,
ca sempe benedico,
li bracce m'aparive 'mpietto m'astrignive.
Chine de passione
currevo 'mbraccio a tte.
Ma tu ca si 'nfamona,
cu tutt'e dduje uocchie e a vedè!
Ma chillu tiempo antico
te si scurdate, ojnè?
Penzanno 'o tiempo antico,
che ne sarrà de me?
Penzanno sempe o tiempo antico,
che ne sarrà de me?
Oltre alle canzoni, al tenore napoletano sono dedicati dei musei:
Museocaruso
Villa Caruso – Bellosguardo
The Enrico Caruso Museum of America
Ristorante Museo Caruso


 Nicola Valente
Nicola Valente  Libero Bovio
Libero Bovio  1921
1921